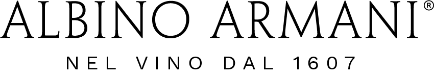L’impero di Albino Armani si espande
Sommario
«Che cosa rende memorabile un vino? Non il prezzo, non la fama, non i punteggi delle guide, ma la sua capacità di comunicare l’identità di un territorio, caratteristica questa che lo rende unico, perché nessun posto, nessuna cultura, nessuna tradizione è replicabile altrove».
Parole sante pronunciate dall’imprenditore trentino di nascita, veneto d’adozione, Albino Armani, un visionario che vive l’impegno della sua famiglia (in viticoltura da oltre 400 anni) con una passione che ha trasformato i sogni in realtà.
Porta la data del 7 dicembre 1607 l’atto notarile che attesta il passaggio di proprietà dal patriarca Simone Armani al figlio Domenico di un terreno «arativo con arbori e vigne» a Manzano, frazione di Mori, località Torreselle. È l’iniziò della saga degli Armani. Una famiglia di contadini senza blasone, ville e palazzi nobiliari, ma che ha trovato in Albino Armani l’interprete illuminato che ha trasformato i vini «sfigati» (sono parole sue), da battaglia, della Valdadige, in autentiche gemme che oggi hanno conquistato i mercati mondiali. Vini primordiali, sinceri, genuini che, seguendo il corso del fiume Adige, parlano più lingue e dialetti: il tedesco, il trentino e il veneto.
«I fiumi – ripete spesso – sono un’autostrada: di scambi commerciali, di esperienze, di confronti. Sono una risorsa fondamentale per la viticoltura». Ecco spiegato il motivo per cui, dopo la Vallagarina, la Valdadige, la Valpolicella, non ha avuto dubbi nel legare l’acquisizione di nuovi poderi e tenute a ridosso dei fiumi: il Mincio con i vigneti a ridosso di Peschiera del Garda, il Piave nella Marca trevigiana, il Meduna nelle Grave del Friuli, il Tagliamento nelle Prealpi Carniche.
«Noi trentini siamo gente di frontiera e amiamo la nostra terra»
Il merito di Albino Armani è di avere unito il pragmatismo alla visione. Fisicamente esile, seppur alto di statura, parla a bassa voce, quasi con timidezza – questo il ritratto del winemaker friulano Walter Filiputti – ma dentro ha la tempra dell’acciaio per la determinazione nel perseguire i suoi sogni. “Nomen omen” direbbero i latini. Infatti Armani è la contrazione dei nomi Armanno e Ermanno, a loro volta declinazione del sostantivo di matrice longobarda “hariman”, arimanno.
A proposito dei Longobardi va ricordato che furono proprio quelle popolazioni germaniche a sviluppare per prime, fin dalla metà del IV secolo, l’idea di una unità territoriale in Trentino. E non è un caso, come vedremo, che proprio il concetto di territorio emerga costantemente nelle scelte imprenditoriali di Albino Armani.
«Sentivo forte la volontà di trovare un’identità per la mia terra – racconta – noi trentini siamo gente di frontiera e lo testimonia il vigneto ultracentenario prefillossera della Foja Tonda, sulle rive sabbiose dell’Adige, dove è presente un cippo in pietra che segnava il confine tra l’impero austriaco e la Serenissima Repubblica di Venezia prima della Guerra 1915-18. Chi vive ai confini di un Paese accumula una ancestrale capacità di guardare oltre i limes e acquisisce una elasticità mentale e una flessibilità che costringono quanti ci vivono ad interrogarsi e a mettersi in discussione. La flessibilità è un valore fondamentale: oggi chi è rigido, statico, inamovibile non può stare al passo con i tempi e con un mondo che corre alla velocità della luce in tutti gli ambiti: dall’economia alla tecnologia, dalla cultura agli usi e costumi».
La “libreria” vivente dei vitigni autoctoni della Vallagarina
Queste riflessioni hanno portato Albino Armani nei primi anni Novanta del secolo scorso a varare un progetto – era il suo sogno – per ridare dignità ai vitigni storici della Vallagarina spesso bistrattati: in particolare il Lambrusco a foglia frastagliata, la Casetta, la Foja Tonda. E a ottenere, con il supporto di un gruppo di lungimiranti produttori della Valdadige, trentini e veronesi, la creazione della Doc “Terra dei Forti”, denominazione che si identifica con le numerose fortificazioni presenti sul territorio. Oggi ha numeri incredibili: 390 ettari di vigneti di proprietà, 7 milioni di bottiglie, 38 etichette (bianchi, rossi, spumanti).
È così che in quel di Ceradello (frazione di Dolcé), accanto alla cantina, ha realizzato una vera e propria “libreria” vivente dei vitigni autoctoni della Vallagarina, un vigneto che ha chiamato “Conservatoria” dove ha piantato alcune “reliquie” di viti abbandonate che rischiavano l’estinzione: la Valderbara, la Cordera, la Negrara, la Turca, la Portoghese, la Peverella, la Vernazza, la Vernazzola, la Corbina, la Corbinella, solo per citarne alcune. Da Chizzola a Dolcé, dalla Valpolicella al Piave, dalla Valbelluna al Friuli.
Sorretto da questa filosofia, Albino Armani, da Chizzola, minuscola frazione del comune di Ala, ha allargato i propri orizzonti dapprima al Veneto (partendo da Dolcè, core business dell’azienda, per insediarsi poi in Valpolicella, nella Valbelluna, nella Marca trevigiana con l’acquisizione a San Polo di Piave di Casa Belfi dove produce dei vini biodinamici) e successivamente in Friuli Venezia Giulia, zona Magredi (provincia di Pordenone) con l’acquisto di un terreno (92 ettari) a Sequals, il paese di Primo Carnera, ai piedi dei colli pordenonesi. Una landa desolata di sassi (“claps” in dialetto friulano) che solo un visionario come Abino Armani poteva trasformare in un vero e proprio giardino con cantina dotata delle più moderne tecnologie. Esperienza replicata qualche anno dopo, sempre nei Magredi, nella vicina frazione di Lestans: 35 ettari dove produce lo spumante brut metodo classico Ribolla Gialla.
«Sono trentino di nascita – racconta Albino Armani che nel maggio scorso è stato rieletto all’unanimità presidente del Consorzio di tutela dei Vini Doc delle Venezie – e il Friuli, anche per una questione di vicinanza geografica, è sempre stata una mia passione fin da ragazzo quando ho mosso i primi passi nel mondo della viticoltura. È una regione tanto complessa quanto affascinante, il segreto è entrarci in punta di piedi e con umiltà».
L’ultima acquisizione: Valeriano sul fiume Tagliamento
Un approccio gentile che gli ha consentito di acquisire, sempre in provincia di Pordenone, ai piedi delle Prealpi Carniche, un terreno diverso dai Magredi, in quel di Valeriano, nel comune di Pinzano al Tagliamento, fiume che ha l’ambizione di diventare patrimonio dell’Unesco come corso d’acqua tra i meno antropizzati d’Italia, ricco di storia, cultura e biodiversità. In quell’area molti anni fa, grazie ad un altro visionario, Emilio Bulfon, a ridosso dei boschi furono scoperti e strappati all’oblìo numerosi vitigni autoctoni (Sciaglin, Cividin, Cjanorie, Forgiarin, Ucelut, Piculit Neri) che ci raccontano di una fiorente viticoltura locale, poi abbandonata a causa del fenomeno delle emigrazioni di cui la Pedemontana friulana ha sofferto.
Venuto a conoscenza di questa realtà, Albino Armani, non appena gli è capitata l’opportunità, ha acquistato un podere proprio a Valeriano dove ha implementato queste antiche varietà contribuendo così al rilancio della zona sul modello del salvataggio della Foja Tonda in Vallagarina.
La cantina sorge sulla vecchia struttura dell’azienda agricola Vicentini-Orgnani. Una nuova sfida in un’area incontaminata delle Alte Grave del Friuli, le mitiche Terre di Plovia (dal nome di un’antica dinastia feudale del Friuli) recuperate attraverso un lavoro di ricerca e valorizzazione del territorio. Così come Ermanno da Pinzano mille anni fa ha custodito queste terre, allo stesso modo oggi Albino Armani custodisce e valorizza questo patrimonio storico e culturale.
Quegli antichi cammini percorsi dai pellegrini ai margini dei vigneti I vigneti delle Terre di Plovia, posti su una splendida balconata, osservano dall’alto lo scorrere lento del fiume Tagliamento, oltre il quale s’intravvede il profilo della collina sulla quale sorge San Daniele del Friuli, famosa nel mondo per il prosciutto con lo zampetto, le troticolture, ma anche per il convento dei monaci dove sostavano i pellegrini che percorrevano il cammino che dal Nord Europa li portava ad Aquileia e poi in Terra Santa. Sentiero che passava ai margini dei vigneti, sempre all’interno delle Terre di Plovia, per poi scendere nella vallata del Tagliamento. Motivi tutti che hanno ispirato Albino Armani a denominare i primi due vini: “Flum” (fiume in friulano, in omaggio al Tagliamento) per il vino bianco e “Piligrin” (pellegrino) per il vino rosso.
Il logo è tratto dal sigillo del fondatore del Castello di Pinzano che domina l’altopiano di Valeriano e i vigneti dell’azienda, la cui dicitura recita: “S (sigillum) Armanni de Pinzano”. Una curiosa assonanza con gli Armani di Chizzola.